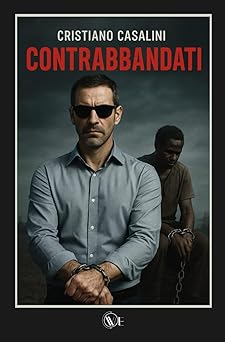Più di trent'anni fà, un ex professore d'italiano, avuto durante le scuole superiori, ci diede da svolgere un tema dal titolo molto particolare ed estremamente complesso.
Inutile ripeterlo, penso l'abbiate capito.
In quel momento lo odiai, concentrando i miei pensieri su di lui e non sull'argomento, gli diedi, in cuor mio, dello scemo, lo fecero tutti, quindi ero convinto di essere nella ragione.
Sono passati più di tre decenni da quel giorno e, come per incanto, ho avuto l'intuizione.
Mi piacerebbe poterlo incontrare nuovamente, e scusarmi per aver pensato male di lui; facendomi un pò di giusta autocritica devo ammettere che, forse, lo scemo, quel giorno, ero io, perché non ero abituato a pensare abbastanza per capire, e focalizzare la mia concentrazione (scarsa) verso ciò che conta.
Era un tema difficile? Certo! Ma fatto per il nostro bene, il suo obiettivo era di farci migliorare, farci alzare l'asticella e, possibilmente, farcelo fare subito, perché un domani sarebbe stato troppo tardi (quel domani arrivò, ma trattasi già di..."ieri").
Lo disse anche
Tim Cook, quando ci onorò della sua visita presso la Bocconi di Milano.
Averlo capito solo ora, con notevole ritardo, mi ha fatto venire così tanti rimpianti dall'arrivare a pensare che, forse, sarebbe stato meglio restare nell'ignoranza, e non averlo capito mai.
Ma un piccolo cruccio mi voglio togliere, perché se è vero che è anagraficamente troppo tardi per crescere in certe aree della vita, non lo è per altre, compreso lo svolgimento di quel tema che non ho ancora dimenticato
In tanti modi avrei potuto svolgerlo, tanti buoni temi avrei potuto scrivere.
Avrei potuto scrivere un tema politico, un tema filosofico, un tema spirituale, un tema esistenziale, tanto per fare alcuni esempi.
Ed invece? Tutto ciò che partorii la mia mente bacata di allora, indolente allo studio, fu una schifezza degna delle gesta di Pierino, il personaggio televisivo recitato divinamente dal compianto Alvaro Vitali.
Visto che non lo feci allora, proverò a farlo oggi.
************
Andando dietro alle mie passioni, gli darò un'impronta economica, sia da un punto di vista macro sia da un punto di vista micro.
Oggi prenderò in considerazione il macro, sarà un articolo diviso in un paio di puntate, seguendo la falsariga degli articoli, da me scritti qualche anno fà, relativi all' Avventura di un povero cristiano
************
Il primo argomento che mi viene in mente, rileggendo il titolo, riguarda l'attuale Europa, alle prese con una sorta di contraddizione interna.
La considero, anzi ci consideriamo una società opulenta, in quanto ci troviamo (almeno per il momento) in una delle aree più ricche al Mondo, con standard di vita alti o, per certi verti versi, addirittura altissimi.
Una ricchezza, la nostra, esclusivamente figlia di un passato ormai remoto, dedito a lavoro, sacrificio e che, unito al boom economico dei memorabili anni sessanta, aveva posizionato molti dei nostri Paesi, fino alla fine del vecchio secolo, tra le prime potenze mondiali economiche.
Considero, d'altro canto, che tutto ciò abbia sviluppato una cultura pauperistica, che ha contribuito a farci smettere, da tempo, di valorizzare la ricchezza incentivando la crescita, coltivando piuttosto una mentalità volta ad ostacolare chi vorrebbe produrre ed investire.
E' ormai scomparsa la voglia di sacrificarsi, per fare spazio ad un più comodo atteggiamento passivo ed improduttivo.
Eppure ho l'impressione che, qui da noi, in Europa (e l'Italia non fa certo eccezione) ci si concentri più su:
- diritti (spesso non accompagnati ai doveri)
- godersi la vita
- protezione di privilegi storici e datati, ma soprattutto ingiusti (vogliamo parlare dei vitalizi per i nostri amati politici? e, perché no? delle baby pensioni? No, poi divento antipatico)
D'altro canto, c'è poca attenzione ad investire sulla produzione reale e , soprattutto, sulla ricerca e sulla cultura.
La contraddizione è evidente
ci si lamenta della concorrenza globale (contemplata peraltro dalla democrazia) incolpandola per la nostra perdita di competitività, invece dovremmo agire per esserlo anche noi.
Ci si rifiuta categoricamente di prenderlo in considerazione, come se fosse il male, eppure la storia insegna che l'unico approccio che ha arricchito gli Stati, è stato quello capitalistico (adottato, tra l'altro anche dalla Cina, nonostante il governo sia comunista).
************
Il rischio, per noi europei, è alto ed il Presidente dell'Argentina Milei, al W.E.F. del 2024, ne ha apertamente parlato
Ha sostenuto che, se non cambieremo velocemente, rischieremo di fare la stessa fine del suo Paese, passato, in soli 150 anni, dall'essere uno dei più ricchi ad uno dei più poveri del Mondo.
Al momento, a diciotto mesi di distanza, non c'è stata alcuna reazione al monito, se non di scherno nei suoi confronti, per il modo colorito e pittoresco di presentarsi al pubblico, ma i giorni, i mesi, e gli anni stanno volando via, e la situazione sta solo peggiorando......
ed i dazi, appena imposti da Trump (additato, dalle nostre parti, come il colpevole di turno, e di tutto), metteranno a nudo tante difficoltà.
Ma i problemi erano già esistenti,
qualcuno l'aveva già detto in tempi non sospetti, solo che, fino ad ora, i nodi non erano venuti al pettine, probabilmente
a breve accadrà.
Sta a noi decidere se restare una società opulenta che si consuma lentamente (ma non troppo), o se ritrovare il coraggio di produrre, di investire e di innovare.
La storia non aspetta, o torniamo protagonisti o saremo solo spettatori.
Scritto ciò, ti saluto! Non perderti il prossimo articolo o, meglio ancora, il prossimo tema :)