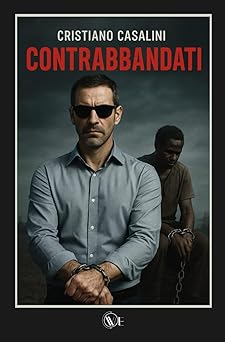Viviamo nel tempo dell’abbondanza apparente.
Ogni giorno, in ogni ambito, siamo sommersi da un diluvio di possibilità.
Al supermercato ci sono dieci varianti di ogni prodotto, su Netflix mille film che non guarderemo mai, sui social milioni di vite da cui lasciarci suggestionare.
Sullo sfondo, una promessa implicita: più opzioni hai, più sei libero.
Ma è davvero così?
La libertà di scegliere è diventata una trappola dorata.
Perché non è accompagnata da un criterio, da un’educazione al discernimento.
Siamo liberi di scegliere tutto, ma senza sapere cosa vogliamo davvero.
Il risultato è l’ansia. E il paradosso: più possibilità abbiamo, più sentiamo di sbagliare.
La psicologia lo ha chiamato paradosso della scelta.
Il filosofo Zygmunt Bauman parlava di “vite liquide” che scorrono senza forma, disgregate da un eccesso di decisioni reversibili.
Ogni opzione scartata diventa un piccolo lutto, ogni scelta fatta è un dubbio che si accumula.
Non è più l’epoca del “non posso”, ma del “potrei”.
E questo è il suo veleno. Perché la vera follia non è l’assenza di possibilità, ma il loro eccesso.
Una follia sottile, elegante, vestita da libertà.
A ben guardare, la nostra epoca ha qualcosa di claustrofobico.
Viviamo nello spazio aperto delle infinite alternative, ma spesso come criceti in una ruota: liberi, certo, di scegliere il gusto dello yogurt o il colore dell’iPhone, ma non la qualità del nostro tempo o la profondità delle nostre relazioni.
E allora la domanda è semplice, ma scomoda: siamo davvero liberi, o siamo solo consumatori di scelte?