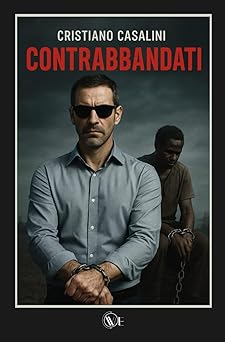Viviamo nell’età dell’ansia.
Non quella episodica, passeggera, ma quella cronica, collettiva, quasi strutturale.
È un’ansia che si respira, che si trasmette come un virus invisibile, tra le righe di ogni notifica, nei silenzi di una call, nelle pause di scroll compulsivi, tra un social e l’altro.
È un’ansia senza oggetto definito, ma onnipresente.
L’ansia di non farcela. Di non essere abbastanza. Di restare indietro. Di non apparire all’altezza.
Di non poter competere in un mondo che premia l’immagine più della sostanza, la velocità più del pensiero, il possesso più della serenità.
E allora, cosa si fa? Si compra.
Non per bisogno, ma per anestetizzare l’angoscia. Si acquistano vestiti mai messi, accessori inutili, gadget identici a quelli già posseduti.
Si spendono centinaia di euro per un cellulare nuovo che fa le stesse foto del vecchio.
Si compra per illudersi di controllare qualcosa, di gestire l’instabilità. Di zittire l’ansia.
Il consumismo ha trovato un alleato insperato: la fragilità emotiva.
L'ha colonizzata. E la risposta al malessere individuale non è mai un’analisi, una presa di coscienza, un cambiamento culturale. È uno sconto. È un'offerta imperdibile. È un “compralo ora”.
E guai a non trovare il prodotto sullo scaffale!
Ma se compri per fuggire da ciò che sei, non stai colmando un vuoto. Lo stai arredando.
Eppure, tutto questo non si chiama più nevrosi.
Si chiama “trend”. Si chiama “retail therapy”.
Si spaccia per libertà di scelta ciò che è solo una reazione condizionata e che, talvolta, arriverei a chiamare pazzia.
Si normalizza la dipendenza. Si premia il debito.
E il risultato è una generazione piena di oggetti ma povera di pace.
Siamo circondati da merci, ma soli. Connessi, ma insicuri. Aggiornati, ma inadeguati.
L’età dell’ansia non si combatte con una carta di credito.
Si combatte con pensiero critico, consapevolezza e – soprattutto – con la capacità di stare nel silenzio senza il bisogno compulsivo di riempirlo con qualcosa.
E questa, oggi, è forse la forma più radicale di ribellione.