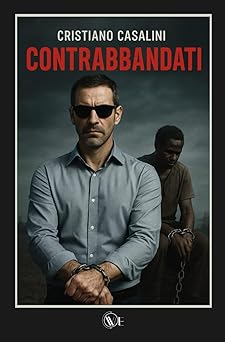Non ce ne siamo accorti subito.
All’inizio era pratico, comodo, utile.
Poi è diventato costante, pervasivo, irrinunciabile.
I dispositivi digitali – smartphone, tablet, orologi intelligenti – sono entrati nella nostra vita con la promessa di farci risparmiare tempo.
In realtà, ce l’hanno portato via.
Non è solo una questione di ore passate davanti a uno schermo, ma della qualità di quel tempo.
L’attenzione viene continuamente frazionata, interrotta, risucchiata da notifiche, messaggi, aggiornamenti, algoritmi pensati per tenerci lì. Presi. Distratti. Connessi eppure lontani da tutto ciò che conta davvero.
Lo psichiatra Paolo Crepet ha lanciato più volte l'allarme
Stiamo crescendo generazioni che non sanno più uscire di casa.
Che preferiscono la sicurezza di una camera e uno schermo, alla libertà incerta del mondo reale.
È l’abitudine che anestetizza, la ripetizione che paralizza.
Si perdono capacità relazionali, si annulla il desiderio, si rinuncia al rischio.
Ma senza rischio non esiste crescita. Né identità.
Forse è tempo di disconnettere per ritrovare il tempo.
Non quello dei device, ma il nostro.
Perché se non scegli tu a cosa dare attenzione, qualcun altro l’ha già scelto per te.
E stai vivendo la tua vita con il timer di qualcun altro.