Non temiamo più la morte.
O, forse, non ce lo concediamo.
In un mondo che esalta la performance, l'efficienza e l'eterna giovinezza, la morte è diventata l'ultimo tabù.
L’unica vera offesa.
Qualcosa da nascondere, da rimandare, da combattere con ogni mezzo.
E allora si moltiplicano le promesse di immortalità.
Tecnologie che conservano i dati del nostro cervello, start-up che inseguono l’elisir di lunga vita, estetica che cerca di congelare il tempo.
L’invecchiamento non è più un processo naturale, ma un errore da correggere.
Come se la vita avesse senso solo se può durare per sempre.
Ma c’è un problema: mentre cerchiamo di sfuggire alla morte, stiamo smettendo di vivere davvero.
L’ossessione dell’immortalità produce una nuova forma di ansia.
Un’ansia sottile, moderna, che ci costringe a rincorrere costantemente l’idea di una vita perfetta, sana, ininterrotta.
Come se ogni ruga fosse una sconfitta, ogni pausa un tradimento.
Come se il tempo non fosse più qualcosa da abitare, ma da conquistare.
Il paradosso è feroce: più rincorriamo la durata, più smarriamo il senso.
Perdiamo l’intensità. Ci dimentichiamo che vivere ha valore proprio perché finisce.
Che ogni scelta ha peso perché non possiamo tornare indietro. Che ogni istante è irripetibile, e per questo prezioso.
È qui che la riflessione torna necessaria: siamo davvero più liberi se potenzialmente eterni?
O rischiamo di diventare schiavi di un tempo illimitato, ma svuotato?
Forse dovremmo imparare da chi, nella consapevolezza della fine, ha trovato la forza di vivere con autenticità.
Forse l’immortalità, più che una conquista, è una tentazione.
E forse è nella finitezza che la vita trova il suo significato più profondo.
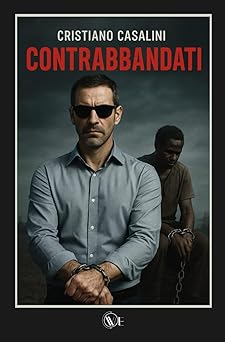
Nessun commento:
Posta un commento