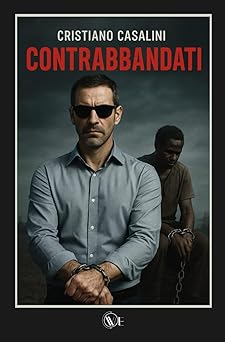La società ci dice che dobbiamo brillare, che dobbiamo emergere.
Il nostro valore sembra essere legato alla nostra visibilità, a quanto riusciamo a farci notare in un mondo che corre veloce.
Brillare è diventato sinonimo di successo, di realizzazione, di felicità.
Ma a ben vedere, questo concetto di "brillare" sembra più una trappola che una vera aspirazione.
È una luce che ci acceca, un riflettore puntato sulla nostra esistenza che, anziché farci vedere chi siamo davvero, finisce per nascondere tutto ciò che c'è di più autentico in noi.
La ricerca spasmodica del brillante, del visibile, non ci insegna a pensare in modo indipendente, a scoprire la nostra strada, a capire cosa vogliamo veramente dalla vita.
Ci insegna piuttosto a conformarci, a seguirne le regole, ad accettare, senza riflettere, che il nostro valore dipenda da quanto possiamo apparire.
E ora viene il dubbio che mi turba
Una domanda che cresce dentro di me: siamo davvero sicuri che la società si sia dimenticata di insegnarci a pensare in modo indipendente?
E se, invece, fosse voluto? Se fosse proprio questa la strategia? Se fosse necessario che non pensassimo, per evitare che ci facessimo troppe domande?
Un pensiero critico potrebbe spingerci a mettere in discussione le fondamenta su cui poggia il nostro mondo, le stesse fondamenta su cui si costruiscono il consumismo, l’obbligo di essere sempre in competizione, il bisogno di apparire.
La verità è che non siamo mai stati educati a pensare veramente
Non siamo stati mai davvero invitati a comprendere il valore di un pensiero libero.
In un mondo in cui si premia l'apparenza, in cui si promuove la superficialità, dove la bellezza esteriore viene anteposta a quella interiore, il pensiero autonomo diventa pericoloso.
Perché? Perché un individuo che pensa in modo indipendente non può essere facilmente controllato, non può essere facilmente indirizzato, manipolato.
Ecco perché, forse, a nessuno conviene che si impari davvero a pensare.
A volte, sembra che il vero obiettivo sia proprio questo: fare in modo che ci arrendiamo all'idea che il pensiero critico non sia necessario
Che ci basti essere condotti dalla corrente di quello che ci viene detto, dai messaggi che ci arrivano da ogni angolo, dalla pubblicità, dai social, dalla politica.
"Non è importante cosa pensi, è importante cosa mostri".
È più facile tenere le persone a bada quando non si pongono domande, quando non si sforzano di scoprire la verità, dietro le illusioni che ci vengono offerte come realtà.
Il nostro mondo, che ci chiede di brillare, ci sta anche chiedendo di smettere di pensare. E questo è pericoloso. Perché quando smettiamo di pensare, smettiamo di essere liberi.
Il paradosso, ovviamente, è che tutti vogliono brillare
Ma nessuno si chiede più se il riflesso, che vediamo nello specchio, sia davvero il nostro.
Se quello che ci viene detto di desiderare, sia davvero ciò che vogliamo, o se siamo solo marionette, tirate da fili invisibili che ci spingono a volere sempre più, sempre meglio, sempre più visibile.
In fondo, non è che la libertà, la vera libertà, sia proprio un pensiero indipendente che si fa strada nel buio, senza bisogno di brillare per essere visto?
Quindi, mi chiedo, siamo davvero liberi in questa corsa al brillante, o siamo soltanto prigionieri di un sistema che ci insegna a non pensare per tenerci sotto controllo?